

Indagine su un insuccesso annunciato, sulle ragioni di un disprezzo condiviso e su un progetto tanto voluto quanto frainteso. Ma il flop di “Cats” in fondo ha soltanto bruciato una delle sue sette vite. La rinascita jellicle prima o poi arriverà…
Cats, le “allucinazioni perverse” del Web e la critica hater
E’ d’obbligo, ancor prima di analizzare criticamente questo adattamento cinematografico dell’opera di Andrew Lloyd Webber, fare una premessa di carattere socio (e social) tecnologico circa la singolare ricezione mediatica di cui l’operazione è stata oggetto dall’apparizione del trailer fino all’arrivo in sala. Perché i numeri che la precedevano (“Cats”, lo spettacolo originale, vanta ben 39 anni di tenitura fra i palchi del West End, Broadway e nel resto del mondo) potevano far pensare solo ad un trionfo cinematografico o almeno a un solido successo commerciale. Invece non soltanto la magia non si è ripetuta così come ci si attendeva (al momento siamo a 74 milioni di dollari worldwide contro i 95 dei costi di produzione oltre al budget speso in pubblicità), ma è successo qualcosa di peggio. Il film è diventato, prima ancora di essere visto, un inaspettato agente catalitico di scomposte reazioni social, divise tra lo sbeffeggiamento a tema e il puro hate speech da parte di commentatori e addetti ai lavori, e questo solo per via del suo particolare look felino-digitale (necessario per consentire movimenti di attori e performers e mantenere la coerenza dell’habitus teatrale). Inusitati e perfino “clinici” gli effetti collaterali provocati alle strutture neuronali e alle cortecce visive dei navigatori. Si va dal bruciore agli occhi agli interminabili giramenti di testa fino ad incubi notturni con vibrisse, tutte esperienze senso-allucinatorie che la maggioranza dei webbers (frequentatori del web, mica fan dell’autore) ha sentito immediatamente il bisogno di condividere, twittare e instagramare, travolgendo l’intera rete con un unico, autoreferenziale commento negativo. L’avvoltoio di un certo “giornalettismo” ignorante (nel senso che proprio ignorava l’opera, la sua genesi e i suoi contenuti) ha completato quindi il capolavoro determinando -caso più unico che raro- il flop del film nel momento stesso in cui lo annunciava.

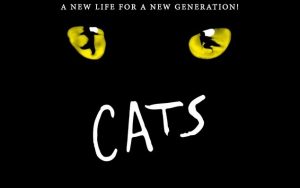
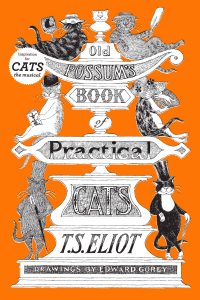
Una crisi di rigetto assai insolita e oltremodo incomprensibile perché ha coinvolto preventivamente tanto la critica (sempre più asservita a una viralità hater in cerca di consenso e ingressi) che gli scafati fan del musical teatrale. Da questi ultimi in particolar modo era lecito attendersi meno intransigenza e più apertura, anche perché consapevoli da sempre che qualsiasi trasposizione cinematografica live sarebbe dovuta passare per le tappe dello sperimentalismo visivo moderno (Spielberg, qui anche co-produttore, negli anni ’90 voleva farne perfino un prodotto d’animazione). E invece “Cats” è stato selvaggiamente demolito dagli uni e dagli altri con una cat-tiveria (è il caso di dirlo) che non ha precedenti nella storia recente. Andate su IMDB e leggete i commenti per farvi un’idea; in mezzo ai tanti “1” autoclonatisi dai precedenti (l’ ingenerosa media voto finale è di 2,80, roba che neppure il peggior horror amatoriale può vantare), troverete un florilegio dell’odio spicciolo che va dal “crimine contro l’umanità” alla “disgrazia”, passando per “il peggior film di sempre”, “oh mio Dio, i miei occhi” e sentenze agghiaccianti come “la mia chemioterapia è stata più piacevole di questa visione”. Ci sarebbe da riflettere approfonditamente su simili esasperazioni dell’umano (dis) sentire ma si sconfinerebbe nel campo ostico -e pure un po’ noioso- della sociologia internauta. L’unica notazione da fare qui si risolve in un placido interrogativo destinato a restare privo di risposta: quale recondito perturbante freudiano avrà mai potuto esumare la visione di questi ibridi umano-felini nell’iride di chi smanetta quotidianamente con le app, tra filtri che asciugano doppi menti, impostano occhioni azzurri e orecchie feline o deformano i sorrisi in ghigni alla Samara? Avatar, Gollum e i 10 anni di motion capture di Zemeckis sono quindi passati invano se poi la visione di “Cats” (no, scusate, del solo trailer) è stata recepita così malamente e senza mai considerare che una simile trasposizione giocava sul terreno del musical, cioè quello, per definizione, dell’astrazione e della sospensione dell’incredulità annunciate.

Mancano l’educazione e l’approccio forse? Oppure, più semplicemente, quel popolo-contenitore non è più educato a soffermarsi sulle questioni e ritiene più comodo delegare il proprio giudizio all’onda che avanza? Del resto la contrapposizione fra soggettivo e oggettivo critico sul web sta cessando progressivamente di esistere in favore di un unico macro-pensiero ondivago e (im)prevedibile, in cui la sostanza è serva del medium mentre il medium, contemporaneamente, si fa nuova sostanza. Nel piccolo/grande caso di “Cats” (ma ne seguiranno altri) il soggettivo (in questo caso “demolire il film ancor prima che esca”) non era altro che uno dei tanti oggettivi condivisibili sui social, di quelli che imperano in virtù della corrente hashtag più forte (la direzione non conta più, basta il movimento) e che, cosa più grave, ha messo inevitabilmente all’angolo ogni discordanza di opinione. Accade così che chi-come il sottoscritto- intendeva difendere non tanto il film quanto il logico diritto di valutarlo solo dopo averlo visto (contrariamente a chi voleva distruggerlo prima della visione o prescindendo perfino dalla stessa) veniva già messo in ombra dalla “maggioranza”, giudicato incapace di veicolare un’opinione verosimilmente “sana”. Chi scrive ama il musical classico e l’arte musicale di Webber e fa parte di quella bassa percentuale di naviganti immuno-resistenti che non ha accusato, dopo la visione del trailer nè bruciori agli occhi nè altri similari effetti collaterali. Solo per questo il web giudicherebbe inattendibile una simile recensione. Perchè già non sintonizzata sulle stesse sarcastiche frequenze dei commentatori e in certi casi sulla medesima ignoranza di un certo giornalismo (alcuni critici americani hanno candidamente ammesso di non aver mai visto il musical a teatro o di non averlo particolarmente amato, però hanno comunque sentenziato su ogni scelta di sceneggiatura, arrivando a giudicare il non-sense del testo di partenza, Il libro dei gatti tuttofare di T.S.Elliot, come “buchi di sceneggiatura”). Tutto ciò appare sconfortante perchè, al di là dell’indiscutibile ed intoccabile diritto del giornalista di valutare negativamente l’opera, priva comunque di credibilità il settore stesso, inficiato già, come in questo caso, da un diffuso sospetto di giustizialismo critico privo di argomentazioni o che, ancora peggio, ha recepito solo il mood di quelle dei social. L’assioma per il quale se gatti, pelo e codine digitali di “Cats” risultano inquietanti per il web allora devono esserlo per tutti, diventa non più contestabile. Non è un caso quindi se le disquisizioni sul cringe (la sensazione d’imbarazzo estetico che si prova nel vedere il film) hanno dominato l’80% delle recensioni reperibili in rete. Ma se il sentire ha talmente influenzato il vedere, siamo davvero certi che il film sia stato realmente visto o sentito? Sarebbe un’altra questione senza risposta ma ci fermiamo qui.

Cinema e Webber, un matrimonio incompreso
Glissando sulle recensioni americane o straniere (quasi copia/incolla fra loro) più impegnate a contendersi il premio per la miglior battuta su palle di pelo e lettiere che ad analizzare l’opera, veniamo al film. E qui bisogna aprire una doverosa seconda parentesi sulle trasposizioni cinematografiche delle opere di Webber, pellicole che mai hanno goduto di particolare fortuna critica. Sarà perché i registi che si sono approcciati alle stesse hanno mantenuto sempre un riserbo quasi ossequioso nei confronti delle strutture teatrali di partenza, facendosi più impaginatori del palcoscenico che interpreti visionari e innovativi (oppure, più prosaicamente, sarà che le opere dell’autore inglese stanno elegantemente sulle scatole a molti critici). Va detto subito che Norman Jewison, in un’epoca in cui il nome di Webber non era blasonato quanto oggi, si potè permettere di fondere un certo sperimentalismo psichedelico anni ’70 con le esigenze del libretto, facendo del suo “Jesus Christ Superstar” un palco hippie, anticonformista e geograficamente metaforico (che se li dimentica quei sempre attuali aerei da guerra che piombano dal cielo intonando Damned for all time a un tormentato black Giuda?). Poi è stata la volta (23 anni dopo) di “Evita” firmato da Alan Parker che ereditava un progetto originariamente nel cassetto di Oliver Stone. Anche lì le grandi firme giornalistiche storsero il naso sia per la scelta di Madonna come protagonista (scelta che in verità diede luogo ad una delle migliori performance della carriera della star e generò indirettamente un’interessante sovrapposizione ideologica fra le due icone pop-politiche) che per la regia di Parker, giudicata più rigida e anonima rispetto alle sue precedenti incursioni in territorio musicale (The Wall, Fame, The Commitments). A dispetto di tanta avversità il film resta godibilissimo e amabilmente teatrale anche a distanza di anni, impreziosito visivamente da una fotografia (di Darius Khondji, quello di “Seven” per intenderci) che esalta la magniloquenza di tutto l’impianto e ogni comparsa impiegata. E ovviamente contribuì ancor di più a diffondere la fama di genio del suo autore (specialmente in paesi come l’Italia, all’epoca saldamente refrattari ai musical su palco). “Il Fantasma dell’Opera” lo seguì nove anni dopo ma, nonostante fastosità e barocchismi alla Baz Luhrman, fece breccia solo in quel pubblico che già conosceva e amava l’opera, o nei cuori dei neofiti che scelsero di andare in sala spinti da curiosità. Joel Schumacher alla regia adeguò per l’occasione il suo stile notoriamente moderno a un classicismo più statico, abbandonandosi alle visioni corali tipiche del teatro e a qualche baroccheggiante movimento sopra i tetti del Palais Garnier. Opulento e sontuoso come libretto comanda, quasi uno Zeffirelli degli anni ’80 trapiantato nel 2000. Luccicò per pochi al botteghino ma alla fine luccicò, grazie come sempre alla magnifica partitura di Sir Andrew Lloyd.




Cats, imperfetti “splendidi fantasmi”
Infine quindici anni dopo è la volta di “Cats”, musical più longevo della storia e pietra miliare della cultura anglo-americana, che con la sua cronaca fatta di pregiudizi e crudeltà web è già la trasposizione cinematografica di Webber più odiata di sempre. Un massacro mediatico ingiustificato a parere di chi scrive, che non ha tenuto conto né della fama del suo regista (Tom Hooper, quello de “Il discorso del Re”, “Les miserables” e “Danish Girl”) o del nobile cast impiegato (Judy Dench, Ian McKellen, Taylor Swift, Idris Elba e altri bravissimi ma meno conosciuti performers), né infine della stessa opera musicale. Gli umani truccati digitalmente come gatti non li ha graziati praticamente nessuno ed ha costituito pure un comodo paravento critico per evitare di addentrarsi nell’opera stessa. Peccato perché è proprio quell’estetica tanto disprezzata e comprensibilmente straniante la chiave d’accesso jellicle al film. Perché è sempre stata lì la questione, anche a teatro. Diventare jellicle e cioè “gattiginosi” proprio come le strofe delle filastrocche dell’Old Opossum T.S.Elliot (cui Webber si è ispirato per i testi) è condizione bislacca e indispensabile per potersi abbandonare a un universo effineffabile, un mondo a misura (o dismisura) di gatto in cui le proporzioni cambiano sempre e il tempo è un’astrazione senza lancette, definita giusto da un pentagramma e dalla turbinosa, colorata scaletta che si sprigiona da esso. Ma se a teatro le regole del patto sono stabilite dalla finzione estetica, al cinema invece non si è perdonato all’estetica di dettarne delle proprie del tutto nuove.



Cats”, sia opera che film, è poi uno sfrontato helzapoppin’ musicale che frulla l’esistenzialismo incomprensibile dei felini con quello razionale degli umani. Per una magica frazione di eterno compresa fra un tramonto e un’alba sontuosamente multicromatici, quelle due filosofie si incontrano ma solo per generarne una del tutto nuova, fatta di iperboli fisiche, visioni folli e plasticamente kitsch (quel che solo il teatro può eleggere a stile) e naturalmente di note, travolgenti e bellissime come sempre. Ed è ancora una volta la musica a farsi interprete di emozioni autentiche e primarie, passerella ideale per gioia, rimpianti e sotterraneamente per il dolore (del vissuto o perfino del non vissuto). Ogni gatto tuttofare dell’opera materializza dunque un frammento di pulsione vitale che va dalla pigrizia (la Jennyanydots dedita a arruolare topini canori ed eserciti di blatte) alla furbizia (Mungojerrie e Rumpleteazer, coppia lestofante), dalla magia sognatrice (mago Mr. Mistoffelees, fa avverare salvataggi impossibili), alla precisione certosina (Skimbleshanks, il gatto del treno con l’orologio accordato sul tip-tap), dalla saggezza anziana che incarna le leggi (Old Deuteronomy) alla semplice disillusione degli anziani (Gus, il gatto del teatro, aspetto smunto ma gloriose memorie di scena). Tutte sono emozioni scintillanti e dignitose, perfino quelle per nulla affabili dei cattivi (Macavity e le sue languidi pin-up). Ma la corda che le unisce tutte resta sempre quella del rimpianto, di cui Memory rappresenta ancora e dopo anni l’intenso e (melo)drammatico manifesto. E’ per mezzo dell’emarginata Grizabella (qui una potente e toccante Jennifer Hudson) infatti che Cats abbatte nuovamente, dopo il teatro, la sua invisibile quarta parete, grazie a quella celebre aria in cui i motivi del dolore e del ricordo vanno a fondersi dentro un’invocazione che è anche la preghiera dell’artista che chiede di non essere dimenticato dal suo pubblico. Perché non servono le sette vite avventurose di un felino per essere felici; basta solo il ricordo di una singola vita ben vissuta. Webber lo disse ben 39 anni fa e lo fa anche oggi in questa trasposizione pop e a misura di bambini (forse l’unico pubblico che potrebbe guardarla con occhi jellicle e privi di malizia), accarezzata dai colori e impreziosita da scenografie (pattumiere, tetti, cucine, stanze incustodite) che definiscono il gatto e la sua fantasmagorica, irrazionale cosmogonia.

Alla già nota Memory poi Webber aggiunge qui un nuovo, bellissimo contro-canto. Che parla di splendidi fantasmi, di esistenze non ancora vissute e cassetti senza memorie. “Beautiful Ghosts” (anche l’esclusione della canzone dagli Oscar è stata conseguenza del tritacarne critico di cui sopra) dice delle sorti di chi è piombato nel mondo dopo aver stracciato il sacco dentro cui era stato imprigionato. Victoria, candida e verginea (bravissima Francesca Hayward, voce e volto d’angelo) canta di quella vita mai provata e di un rifiuto che è forse più doloroso dei brandelli di esistenza che Grizabella almeno può esibire come ferite sopra un manto disadorno. Il jellicle per un attimo si fa angelical e mentre Victoria indora la sua malinconia di melodiosa, felina dolcezza, “Cats”- il film si denuda davanti ai nostri occhi per ciò che è più profondamente; l’atto frainteso di un artista che ha peccato per troppo amore e che solo per questo è stato respinto. Un rischioso gesto cinematografico quello di Tom Hooper che ha avuto origine da un equivoco generato sopra quel sentimento, dall’errata convinzione che una simile devozione potesse essere condivisa. E così, nel tentativo di restituire ad altri la propria passione attraverso un’opera il più possibile rispettosa sì ma anche moderna, sgargiante e colma di entusiasmo, si è visto respinto da quello stesso pubblico, sbeffeggiato già nelle intenzioni e profondamente deriso per cotanta ingenuità. Fuori tempo massimo non tanto nella concezione (in tal senso anzi il film recupera uno sperimentalismo avventuroso che lo apparenta al lontano “Jesus Christ Superstar”) quanto nell’eccesso di fiducia progettuale. “Cats” è un’immaginazione piena di lucore che proviene direttamente dal passato, un altro sogno (lungo un giorno?) al quale la Hollywood omologata e rendicontata di oggi forse non credeva più, ma è anche una follia che per esistere (e in fondo è un miracolo che esista) aveva bisogno di un proprio garante pieno d’entusiasmo. E’ un flop “Cats”, un film condannato prima di essere visto o solo perchè è venuto al mondo, proprio come il sacco lanciato tra i bidoni all’inizio. Però resterà anche uno “splendido fantasma”. Imperfetto certo, gommoso e kitsch ovviamente, infantile e gattiginoso naturalmente, ma anche vibrante e sotterraneamente doloroso. E come tutti i fantasmi di una vita non ancora vissuta attenderà nell’angolo di una strada piena di rifiuti la sua futura e dovuta rinascita jellicle. Basta solo aver pazienza. Another day is dawning…
Andrea Lupo



























Commenti recenti