

Che cos’è un “classico”? Nell’accezione più semplice e lineare del termine un classico è tutto ciò che è diventato modello, archetipo di bellezza e perfezione cui aspirare (ed ispirarsi), paradigma formale e sostanziale di qualcosa che è nato per durare nel tempo e “permanere” nella memoria.
In senso disneyano il classico animato è nato praticamente subito, in quel lontano (eppure già avanguardistico) 1937 di “Biancaneve e i sette nani”, primo lungometraggio “disegnato” figlio di una visione ed una sperimentazione nuove e, fin da subito, incredibilmente audaci. Da allora in poi fu tutto un susseguirsi di stili, riletture fiabesche mai viste, esplosioni grafico-cromatiche sconvolgenti e creazioni musicali destinate a radicarsi dentro le cortecce cerebrali di intere generazioni. Sono passati 100 anni dalla fondazione degli studios di Burbank ad opera dei fratelli Walt e Roy, 87 invece da quel primo, seminale lungometraggio. L’animazione disneyana ha conosciuto stagioni e fortune di ogni tipo, corsi e ricorsi creativi, personaggi e stereotipi amati o stigmatizzati. L’idea di classico, nonostante tutto e nonostante la “biforcazione” Pixar dell’ultimo trentennio, è sopravvissuta ancora dentro la Disney. Come appuntamento quasi annuale e rinnovo di una promessa di sogno e di visione. “Wish”, non a caso, è orgogliosamente, presentato come il 62° classico d’animazione della casa di Topolino, esattamente come lo è stato, un anno fa, l’ingiustamente bistrattato “Strange World” o nel 2021, all’ombra del covid e dello streaming, il coloratissimo “Encanto”. Sopravvive l’idea di classico all’interno di nuovi assetti direttivi e creativi, decisamente virati al femminile dopo il trionfo di “Frozen” e, soprattutto, dopo il rimescolamento sociologico del #metoo. Sopravvive l’idea di classico e sopravvive nonostante i boicottaggi (alquanto infantili) di chi percepisce l’etica inclusiva, abbracciata con parca delicatezza dalla casa, come una disobbedienza nei confronti di codici narrativi mai scritti ma ritenuti ugualmente inviolabili (il giovane avventuriero di “Strange World” NON può essere un adolescente innamorato di un coetaneo maschio, la sirenetta di un live-action NON deve avere un’etnia difforme da quella presente nel cartone di 34 anni prima). Come se simili scelte, una volta inserite, finissero per “viziare” geneticamente l’opera stessa, irrimediabilmente deviata dai suoi fini meramente ludici o, addirittura, subdolamente concepita per scopi di indottrinamento infantile (così come asserito dai folli reazionari che boicottano ogni recente prodotto Disney). Dunque sopravvive ancora l’idea di classico nonostante le accuse di “woke” (parola che la grancassa dei social ha messo in bocca a tanti), di mancanza di novità (al grido di “rivogliamo le principesse!”, non proprio il nuovo che avanza) e, nonostante certi sabotaggi gratuiti veicolati (ah, la coerenza!) da chi dichiara orgogliosamente che non vedrà il film (“perle” social del tipo “ma Wish parla di patriarcato?”, “non vedrò un Disney finchè non la smetterà col politicamente corretto!” sono state all’ordine del giorno durante la campagna promozionale).



Tutto questo per ribadire che, fortunatamente, l’idea di classico sopravvive ancora in Disney, nonostante la temperatura sociale e la rete.
E allora che cosa sopravvive del concetto di classico in quest’ultimo “Wish”, lungometraggio animato che ha l’onere (più che l’onore) di celebrare il centenario della storica casa all’ombra di un presente social mai così tanto sospettoso e maldisposto (perfino nei confronti di un cartone)? Probabilmente molto più di quello che siamo disposti a riconoscere. Perché “Wish” è classico non certo (non solo) perché innervato di elementi ed influenze provenienti da circa ottant’anni di tradizione (nell’incipit è presente anche l’archetipico libro di fiabe col noto corredo di “c’era una volta”), ma soprattutto perché del classico preserva una certa grazia narrativa unita a un indimenticato esercizio della “semplicità”.



Così “Wish”, con la sua storia di desideri spontaneamente donati dal popolo di Rosas al loro Re Magnifico affinchè questi li custodisca per loro promettendo di esaudirne (giusto) alcuni, culla e foraggia proprio quella “semplicità” delle origini, concetto che torna quasi ideologicamente al centro del progetto. Intreccio e complicazioni di trama dunque cedono il passo al peso specifico dell’idea, che qui si fa nucleo “teorico” del racconto (un film che oggettivizza il desiderio) e, fatto inedito, la sua anima politica. Politica perché, va sottolineato, “Wish”, seppur disneyanamente costruito su canzoni e archetipi caratteriali magari blandi e prevedibili, cela, dietro l’ovvia celebrazione del tema (quel wish che un tempo veniva espresso “upon a star”, evocando una stella), la naturale evoluzione del concetto-chiave, quasi una sua rivisitazione moderna. Ed è una revizione che, al netto di ridondanze narrative (il cattivo che “imprigiona i desideri”) e musicali (la canzone “salvifica” che poi li libera), appare perfino sorprendentemente libertaria.



Che cosa ci dicono in fondo quei desideri ceduti dagli abitanti di Rosas al loro Re non appena ciascuno di loro diviene adulto? “Ooh and hey did I mention when you turn eighteen. You get to give your wish in a ceremony?( “Oh, e ho raccontato che quando diventi maggiorenne puoi esprimere il tuo desiderio durante una cerimonia?”). Canta così del resto la protagonista Asha introducendo il ridente villaggio edificato per tramite delle arti magiche dal proprio, autoproclamato (nonchè frustrato), “Re Magnifico”, il quale ha stabilito anche le conseguenze indolori per cotanta “cessione” da parte del suo popolo. “Fa male? Ti fa piangere?” si canta ancora. “Oh, no, and you won’t even miss it when you say goodbye…”( Oh no, e non ti mancherà nemmeno quando gli dirai “addio”). Già perché il desiderio al quale ogni abitante dice addio si libra subito nell’aria trasformandosi in un poetico globo di luce azzurra prontamente “archiviato” nel palazzo del Re. Peccato (o per fortuna) che delle sue reali caratteristiche non resterà traccia nella memoria del legittimo “proprietario”, il quale, dopo un simile “espianto” spontaneo, non soffrirà più per la mancata soddisfazione. A restare è giusto la memoria di “qualcosa” dentro ma sfrondata dai contenuti. E quel desiderio al centro di “Wish” non è nemmeno il sentimento di possesso verso qualcosa che non si ha ancora, ma, più notevolmente, pura “aspirazione” e “realizzazione” di una parte di sé (la parte più importante). In poche parole una fetta di individualità. Gli abitanti di Rosas, cedendo il proprio desiderio al Re, rinunciano dunque a una porzione fondamentale della propria personalità e si sollevano, contestualmente, dal peso di ogni eventuale frustrazione. Lo fanno perché attratti dal miraggio di una soddisfazione “facile” e dalla certezza di restare al riparo dall’infelicità. Il tutto espresso nei pochi versi di una allegra canzone introduttiva. Difficile non intravedere lo schema politico del “controllo” dietro un simile sistema di vita, con al vertice un sovrano (aitante, carismatico e suadente) motivato dall’ego e dall’ambizione frustrata (Re Magnifico in passato non ha potuto realizzare il “suo” di desiderio), che mira ad ottenere ad ogni costo l’adesione popolare (non a caso dichiara -cantando- di proteggere i desideri del suo popolo “at all coast”). Ed è altrettanto impossibile non scorgere dietro una simile dinamica di desideri ceduti “consensualmente” e di ricerca di soddisfazione immediata (od oblio perenne ma “felice”), la scoperta metafora di una autocrazia moderna. Abbigliata dalle vesti (un po’ obnubilanti) della democrazia volontaria ma, pur sempre, un’autocrazia.


Aggiungiamo poi che un tal Re (che magnifico, al di là dei suoi disegni politici, rimane comunque, essendo uno dei vilain disneyani più riusciti e seducenti degli ultimi tempi), quando soddisfa i desideri dei propri abitanti, seleziona cautamente solo quelli che ritiene “innocui”, lasciando nel limbo degli “irrealizzati”(gli “indesiderati”, versione fiabesca dello spam), quelli potenzialmente sediziosi (perfino il canto di un potenziale, menestrello ormai centenario).Siamo ancora sicuri, alla luce di tutto questo, che “Wish” sia davvero quel cartone semplice o banale bistrattato dalla rete? O magari siamo di fronte a uno di quei piccoli e rari casi in cui la classicità animata (mainstream come piace dire ai detrattori) si fa soprabito insospettabile per veicolare un messaggio “sanamente” rivoluzionario (proprio ciò che Re magnifico teme di più)? Il soprabito, va detto, è anche di quelli particolarmente belli, col suo carico di sperimentazione visiva inusuale (la tecnica mista fra gli acquerelli della tradizione, il 2D dell’impostazione paesaggistica e un digitale misuratissimo) e un portato musicale meno incisivo (non ci sono hit cantabili alla “Let it Go”) ma di apprezzabile fattura. Un soprabito saldamente ancorato a quella chimica “classica” degli elementi tipicamente disneyana, in cui tutto (perfino i prevedibili animaletti) sta al posto giusto.
Desideri inesauditi, specchi delle brame (maschili) altrui e canzoni che, da sole, spezzano incantesimi e catene, rinsaldando, almeno nella fantasia, quel sentire comunitario che non è più, coi tempi che corrono, un valore così scontato o facilmente ipotecabile. Riappropriarsi di una parte di sé per (ri)scoprirsi comunità, intonando una canzone che, forse, è più forte di ogni arma. E se Wish fosse, curiosamente, quel piccolo grande inno al pacifismo che nessun potente vorrebbe sentire?
Testo e disegno di Andrea Lupo


























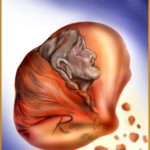
Commenti recenti