
Minari di Lee Isaac Chung
Con Steven Yeun, Ye-ri Han, Yuh Jung Youn, Noel Cho, Alan S.Kim, Will Patton.
Si resta vagamente spiazzati al termine della visione del film di Lee Isaac Chung, ostaggi di sensazioni oscillanti fra appagamento e sospensione, tra la consapevolezza di una riconciliazione familiare avvenuta sotto il nostro sguardo e la malinconica incertezza che i fili esistenziali di quei personaggi terranno ancora (oltre lo stesso sguardo). E’ l’effetto emotivo prodotto da quello stacco su schermo nero immediatamente successivo all’inquadratura di un rigoglioso minari, pianta acquatica giapponese che dà al film titolo, senso e ovviamente un simbolo. Una cesura netta, assai tipica di un certo cinema asiatico moderno, quel cinema che sovente sceglie di elidere la narrazione non tanto sulla soglia del non detto quanto di ciò che è essenziale. Nessun punto di interpunzione o chiose didascaliche tipicamente “occidentali” dunque. Spiazza un po’ e forse la ragione per cui lo fa risiede dentro la sua stessa natura filmica. Perché “Minari” è percepito dallo spettatore esattamente per come è venuto ad esistenza: nella sua ambivalente essenza, condizionata questa da una genesi letteraria che è prima di tutto sintesi culturale ed “industriale”. Un film coreano prodotto dagli Usa (tra gli executives c’è anche Brad Pitt) che narra le vicende di una famiglia asiatica in cerca di fortuna e riscatto nel Nuovo Continente. Una storia raccontata come la più classica avventura di riconquista (western?) del sogno familiare dentro una big country inesplorata, con quella successione di fortune e miserie tipica del cinema americano, fatta di drammi, comicità e tragedie che vanno a sfiorarsi e talvolta pericolosamente ad incrociarsi. Una vicenda in cui il regista riesce a non reprimere la vocazione identitaria del suo cinema sotto i solchi narrativi di un genere fortemente “tipizzato”, facendola invece emergere “rigogliosamente” proprio in mezzo agli stessi. Esattamente come quei germogli del minari che affiorano inaspettatamente in molti luoghi per offrirsi al mondo, foglie che nascono dopo o perfino dentro le calamità, così silenziose nella loro resilienza e nel loro abbraccio rivolto a tutti, vincitori e vinti. E proprio come la più democratica delle pianti aromatiche (paragonabile al nostro prezzemolo), definita così perché alimento che trascende ogni classe sociale, il film non è che la storia di questo innesto umano in terra straniera, quella terra che attrae irresistibilmente chi emigra per quel suo diverso colore e sulla quale la famiglia Yi finirà per imprimere un altro e più personale calore.



Due anime culturali diverse dunque, conviventi dentro la stessa storia (la prima, orientale, quasi ospite dell’altra americana), ma che riescono tuttavia a fondersi in un quadro morbido e solo apparentemente dominato dalla prospettiva (etica, religiosa e perfino paesaggistica) di un sogno a stelle e strisce. Perchè a spiccare di più nel piccolo e delicato affresco di “Minari” non sono la maestosità dei campi o i bagliori uniformi di un sole salvifico e neppure la morale lavorativa “sacrificale” o il sentimento di asilo religioso della comunità accogliente, quanto le “altre” pennellate domestiche, gli insoliti cromatismi familiari e certi inattesi “grumi” intimisti. Perché che cos’è altrimenti la nonna (Youn Yuh-Jung, prima interprete coreana della storia a ricevere l’Oscar) se non quella “tinta forte” che imprime alla storia una deviazione quasi “obbligata” oltre che fondamentale per l’evolversi degli stessi equilibri familiari? Un personaggio il suo che finirà per divenire idealmente quel bastone rabdomante che il capofamiglia inizialmente rifiuta (ma a cui si affida invece il contadino-martire interpretato da Will Patton, altra pennellata eccentrica che ravviva la bucolica prevedibilità di provincia con le sue camminate cristologiche in pieno campo). E di grumi toccanti il film sa essere pudico dispensatore (la scena degli aeroplanini di carta, la punizione del bambino e ogni sequenza conviviale del film), riuscendo a innestarli tutti in modo tenue e mai forzato dentro il tessuto “memoriale” del racconto (perché con la sua ambientazione nei primi anni ’80 “Minari” è già un film di ricordi e di ombre), aiutato in questo dalle magnifiche musiche di Emile Mosseri capaci da sole di evocare timbri e sensazioni di un passato (infantile e non) comune a tutti noi, sgranato e commovente come una foto. E alla fine dell’esperienza (che per il regista Lee Isaac Chung rappresenta per ammissione il principio di una autobiografia) ci si ritrova avvolti da quella sensazione di mestizia mista a sospensione che solo uno schermo nero a fine narrazione sa suscitare. Questo accade perché tutto ciò che è essenziale, e non una parola di più, è stato detto. Ecco allora che si diviene tutti noi come quel minari che cresce ai confini di ogni avversità; avvinti dentro la sua storia, dolcemente radicati nella nostra, inconsapevoli del futuro (nostro e loro) oltre il nero dello schermo, ma ben stretti a quel lembo di foto da cui proveniamo.
Andrea Lupo























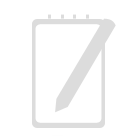



Commenti recenti