

ATTENZIONE: CONTIENE SPOILER DELLA TRAMA. NON LEGGERE SE NON SI E’ PRIMA VISTO IL FILM
Beware of darkness, guardatevi dall’oscurità canta George Harrison nello splendido incipit di “Weapons”, mentre le silhouettes di 17 bambini di Maybrook, Pennsylvania, abbandonano il proprio letto e iniziano a correre attraverso i viali della placida cittadina, classica provincia americana sonnolenta e frondosa già protagonista di centinaia di incubi cinematografici. Corrono, le braccia protese dietro, i corpi in posa “triangolare”, come obbligati da un istinto irrefrenabile, obbedendo a una sirena che nessuno, eccetto loro, può udire. Sono piccoli droni, weapons, “programmati” per la fuga verso un obiettivo ignoto. E come droni invisibili quei figli spariscono dalla vista dei loro cari, annegando tutti nelle medesime tenebre e fra le liriche di una canzone che pare quasi una citazione all’inizio di un romanzo kinghiano. Un incubo ovviamente intriso di dramma, orrore e grottesco, ma anche un racconto dal vago sottotesto “politico” che il titolo, secco, sembra subito voler mettere in evidenza.
Weapons. Perché soprattutto di armi è fatta l’America oggi (di Altman, ma anche di P.T.Anderson, modelli dichiarati per il regista Zach Cregger), e che oggi, probabilmente, lo è anche più di ieri. Così, fra piccoli tasselli di una provincia decostruita dentro e fuori le mura (di case, scuole, vialetti e centrali di polizia), sfilano come petali di magnolia, arsenali fatti di gesti, parole, bullismo e sopraffazione. Armi impugnate come sempre dai “grandi” (assenti, imbelli e prevaricatori) ma anche le armi trasfigurate direttamente nella carne dei piccoli. Perché è chiaro che quelle giovani weapons del titolo rappresentano, metaforicamente, un prodotto della cecità adulta, di genitori incapaci di riconoscere il disagio dei figli (il giovane Alex, unico rimasto nella classe dei 17 scomparsi), di altri che vi instillano i germi della prepotenza (il compagno che lo bullizza), e di adulti totalmente inerti dinanzi al pericolo, incapaci di riconoscerlo quando si presenta sotto le mentite spoglie di parenti lontani o di respingerlo quando assume l’aspetto di un’anziana sciroccata e squittente.
Ed è proprio da quella cecità (e conseguente assenza) dei padri che la società americana ha generato nel tempo la vulnerabilità dei suoi figli, rendendo più docile e semplice la loro transizione in dispositivi meccanici, automatici, privi di identità. In armi appunto, come la visione (simbolica ed angosciante) di quell’enorme mitra sospeso nella notte sintetizza plasticamente davanti a uno dei protagonisti. Una riflessione “politica” tutt’altro che implicita quella di Cregger, ma, anzi, assai diretta e sottilmente incuneata nel tessuto di un’opera sì di genere ma anche stilisticamente “impura” (e sorprendente). Un’opera che si serve del proprio meccanismo di affabulazione (suddivisione in capitoli e punti di vista diversi) quale espediente narrativo “disorientante” ma anche rivelatorio, perché consente di mettere a fuoco, segmento dopo segmento, la sua visione poliedrica di “arma”. Ed è una visione che giunge a completamento quando ne viene mostrata la sua natura imprevedibile e bizzarra: quella proveniente dal folklore e dalla fiaba (occhio ai titoli di testa, già “rivelatori” in tal senso).
Opera programmata dunque ma non programmatica, Weapons, nella sua scansione in atti snocciola scaglie infette della società americana, portando a galla (fra orrore ed ironia) diverse tare sociali ed antropologiche piuttosto note: l’incapacità di liberarsi dall’ansia inquisitoria, la marginalizzazione del diverso (non solo il bambino ma anche il giovane drogato), la violenza dell’autorità, la vocazione, e ricaduta, verso l’esoterico (quel “witch” dipinto sulla fiancata della macchina quando nessuna spiegazione è plausibile). Ed è emblematico che la “svolta” definitiva alla storia provenga proprio dal piano dell’occulto e dell’arcano ed altrettanto lo è che lo svelamento del mistero attinga dalle dinamiche biologiche del parassita o da quelle più politiche del “controllo”. E sono sottintesi che, intenzionalmente o no, aprono ad interessanti e suggestive chiavi di lettura con ovvie ricadute sul presente.
Perché quale differenza passa fra un arbusto intrecciato a fili di capelli attraverso cui “dirigere” i corpi e un piano governativo sul controllo quando l’intento è analogo (agire sulle menti deboli degli adulti e su quelle giovani da cui trarre nuova linfa vitale)? Controllare un corpo prima ancora che questo giunga ad una sua autonoma identità non è forse la via più facile per garantirsi obbedienza e continuità? Chissà se Cregger quando ha immaginato la sua storia è stato mosso dalle medesime suggestioni che oggi, sembrano emergere dal film in modo quasi naturale? E chissà se nell’atto distruttivo finale, violento ed eversivo, non vi sia soltanto l’ovvio annullamento dell’incantesimo ma anche la ribellione infantile dal controllo adulto e la liberazione dall’influsso nocivo del potente di turno.
Strega o MAGA fa poca differenza: di fronte all’ottundimento adulto non restano che i bambini. A loro il compito di “divorare” un cattivo presente per nutrire (con zuppe Campbell?) un diverso futuro.
Andrea Lupo


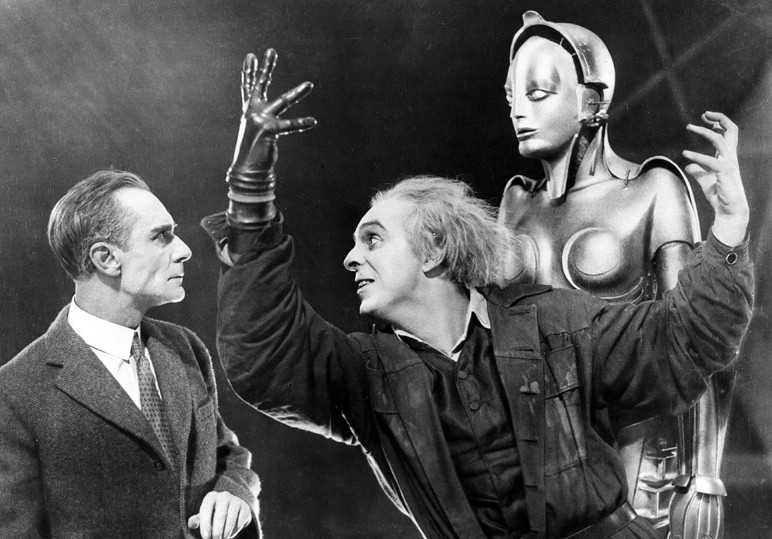


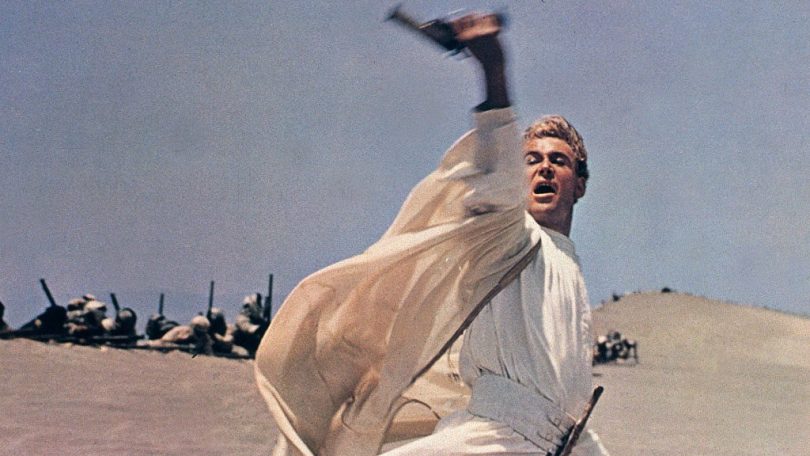



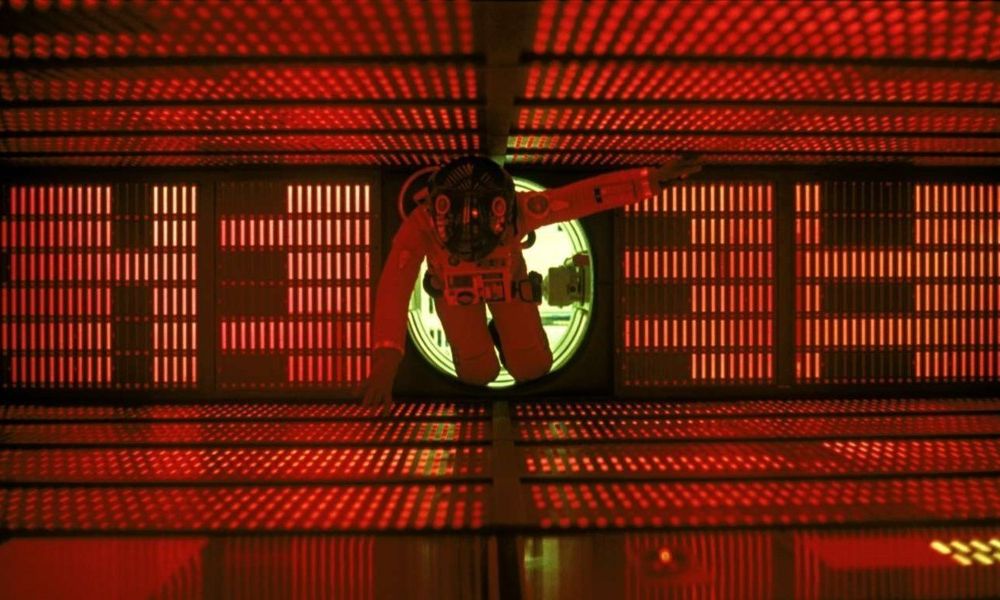
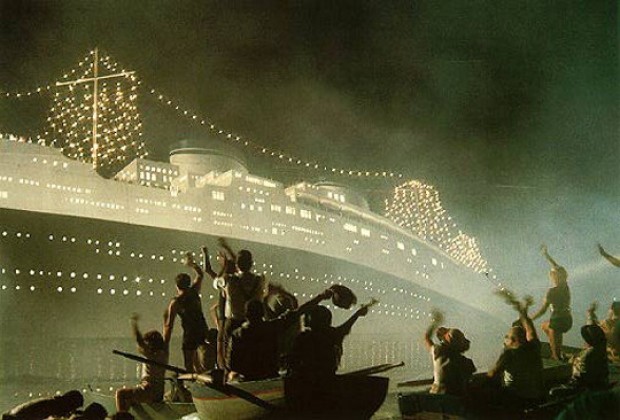












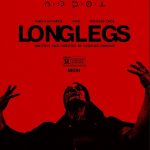
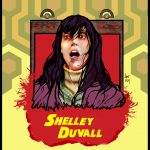


Commenti recenti