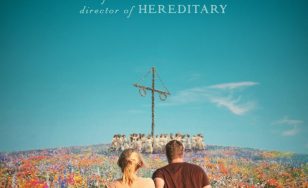
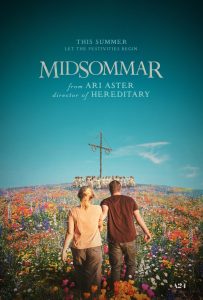
Il folk horror fa paura. Forse più paura dell’horror stesso. Fosco sottogenere che (r) esiste al cinema da quasi 60 anni come una sorta di innesto malato, rappresenta dell’horror la corrente forse più estrema, assai poco conciliante e perfino anti-sistema. Da gemme primordiali filiate fuori dalla Hammer Film come “Il grande inquisitore” (1968, con l’icona Vincent Price) e “La pelle di Satana”(1971) fino a più recenti declinazioni autoriali offerte da opere destabilizzanti e lisergiche come “I disertori” o pittoriche e rigorose come “The VVitch”, questo filone non nasce con specifici intenti finalistici (come ad esempio il più codificato e fortunato sottogenere “demoniaco”, modellato sulle paranoie anni ’70 e intorno al sentimento cattolico della middle-class americana), ma si afferma nel tempo con modalità più indie grazie alla forza di titoli segnanti come quelli sopra citati e attraverso l’espressività di autori come Michael Reeves e Robin Hardy che hanno assunto nel tempo una statura quasi mitologica (al primo, regista de Il grande Inquisitore, è stato dedicato perfino un albo di Dylan Dog che ne ripercorre le oscure circostanze della morte; il secondo è l’autore di “The Wicker Man” del 1973, pietra angolare di tutto il cinema del disagio e capolavoro assoluto del genere). E se il terreno geografico d’elezione del folk-horror resta quasi sempre quello britannico (con sporadiche fughe verso le colonie americane dei primi puritani, vedi The VVitch) il contesto culturale prescelto è quello che muove dalla tradizione popolare campestre fatta di narrazioni orali ed eredità cerimoniali. Una dimensione che ingloba tanto il radicalismo religioso cristiano (che di errori ed orrori è stato nei secoli generosamente foriero) quanto il suo speculare e rimosso -anche dai calendari- antagonista e cioè quel tradizionalismo pagano intriso di ritualità e rune e soprattutto immerso nel culto di una sessualità simbioticamente allineata con la fertilità spontanea della natura. Una ritualità che abbraccio ovviamente anche il sacrificio fisico.



Fa paura il folk-horror perché, a differenza del genere demoniaco da cui mutua essenzialmente incarnazioni e idoli (e non solo quelli appartenenti alla mitologia infernale ma anche gli altri cristiani positivi in nome dei quali si sono giustificati altri medioevi ed abomini), non mette in scena soltanto il classico confronto/duello fra forze contrapposte, ma predilige più la rappresentazione comunitaria all’interno della quale quel confronto è stato già scritto (mentre il duello ha un vincitore predestinato proprio come in “The Wicker Man” e in quest’ultimo “Midsommar”). A contare è dunque la sequenza attraverso la quale viene a compiersi quell’annunciata catarsi collettiva che investe anima e psiche; una liturgia pagana inflessibile scandita da totem di matrice umana e cieca abnegazione fisica ( di se stessi ma anche di altri). Impaurisce questo sottogenere perchè nasce dal bisogno di una retro-comunità (di quelle che resistono al di là della civilizzazione o vivono nonostante la stessa) di affermarsi in fiera opposizione a società e cultura dominanti, contrapponendo al rigido assestamento dei codici religiosi e delle strutture di pensiero borghesi la propria ancestrale quanto orgogliosa libertà devozionale. Per questo il folk-horror può essere definito in qualche modo come un sottogenere anti-sistema; in esso infatti possono convergere tanto allegorie spirituali audacemente liberatorie, quanto torbide metafore di derive sociali allarmanti. Basti pensare a certe sue terminazioni settarie confluite in titoli come “The sacrament”, report documentaristico basato sui suicidi di massa di Jonestown o “Red State” di Kevin Smith, ove il sudario del fondamentalismo cristiano fa da coagulo per una spaventosa deriva omofobica e reazionaria. O basti pensare ancora alle infiltrazioni integraliste presenti nel tesissimo “The invitation” in cui il tema settario è gelidamente declinato in chiave paranoica e anti-sociale (la negazione della community salottiera e del suo pià diretto ed immaturo riflesso, la coppia). Poi c’è il superbo “Kill List”, ricognizione tutta inglese incentrata sulla lenta erosione (o decomposizione già in atto) dei quattro pilastri fondanti della società moderna, così ben sapientemente “occultata” (è il termine giusto) fra i generi da lasciare, dopo la mazzata finale, ancora basiti al solo ripercorrerla. Fa dunque paura il folk-horror oggi? La risposta è sì e la motivazione non è soltanto di carattere estetico/cinematografico (elemento che un suo peso ce l’ha), ma resta prevalentemente semantica. “Midsommar”, ambientato nell’immaginaria Harga durante la celebre festa svedese di mezza estate, ne rappresenta un fulgido, riuscitissimo esempio.


Ari Aster non è soltanto regista che ha dimostrato subito di avere stile e polso giusti per raccontare- come negli anni ’70- il dramma che si insinua nell’horror (o viceversa) ma è anche l’Autore -sì, con la A maiuscola- che ha saputo regalare al genere, e nell’intervallo di appena due estati, rispettivamente canto (Hereditary) e controcanto (Midsommar) di una delle più pessimistiche ed impietose rappresentazioni della cellula sociale generativa, la famiglia. Già nel notevole “Hereditary“, che potremmo considerare un folk-horror calcolatamente dissimulato, il disfarsi del nucleo familiare nello storytelling non era conseguenza diretta dell’irruzione del soprannaturale nel tessuto naturale, bensì il risultato di una gestazione pregressa che affondava le proprie radici nel rimosso, nella follia genealogica e nel fragile perbenismo che li aveva interiorizzati entrambi. La famiglia rappresentata da Aster in tal senso non è solo terreno di prosecuzione e germinazione –ereditarietà appunto- di un culto infernale (da cui l’ipotesi di folk-horror) ma soprattutto solco che si è già (inconsapevolmente?) auto-predisposto per rendere più fecondo l’innesto malefico. Ed è una visione nucleare che, per agghiacciante paradosso, pare ritrovare la giusta saldezza più nello statico e marcescente plastico finale che nella rappresentazione dei legami di cui è proiezione. Legami vivi sì ma anche irrimediabilmente minati da divisioni, irresponsabilità e recriminazioni. E alla fine le trombe del dio Paimon sembrano trionfalmente celebrarla questa grottesca, ritrovata armonia del nucleo originariamente scomposto, facendo sorgere il dubbio di aver assistito più a una pianificata e auspicata rinascita che a un cupo e implacabile annientamento.



Anche in “Midsommar” si assiste a un percorso similmente invertito di senso. Nell’opera seconda di Ari Aster infatti l’albero degli affetti viene subitaneamente e quasi del tutto reciso lasciando giusto un fragile e ancora innevato ramo prima dell’estate: la sopravvissuta Dani. A lei, unica figlia superstite, tocca infatti l’ingrato compito di reggere l’onere e il senso stesso del lemma “famiglia” (diventato fisicamente impronunciabile dopo la tragedia), mentre insufficiente a mitigare le violente amputazioni si rivela già quella residua, forse insincera, proiezione di coppia. Ed è proprio tra le pieghe di questi due deficit emotivi che “Midsommar” inizia il viaggio o, meglio, il proprio delirante percorso iniziatico, con la melodia dei corni infernali del film precedente che lascia il resto dell’esecuzione ai violini, bucolici presagi sonori di nuove devastanti catarsi. Terra, erba, funghi e sole. Il folk-horror per Ari Aster prosegue cinematograficamente da qui, da elementi naturalistici che hanno preso il posto ormai di quelli soprannaturali e dalla devastazione di un’altra cellula sociale dopo quella della famiglia, la coppia. Inadeguato collante delle relazioni, proprio come la consanguineità di Hereditary, e legame incapace di sopravvivere ad ipocrisie (quelle del fidanzato Christian, nome non casuale) ed immaturità originarie (quelle di Dani, bimba forse asessuata espunta prematuramente dal nido). Quella coppia idealmente predisposta ad accogliere il caldo sole scandinavo che penetra bruciante come una pira entro increspature emotive apparentemente innocue. La comunità dell’halsingegard si prende dunque il compito di inglobarla (non prima naturalmente di aver mostrato a Dani e Christian la sua versione ferocemente sublimata), scorporando da essa con modalità ferocemente autoptiche ogni sotto-testo inquinante (il gruppo di amici e il team universitario, l’insolenza dei buffoni e la brama di conoscenza, entrambi ri[con]dotti a feticci simbolici) così da poterla in ultima battuta ridisegnare attraverso folli arabeschi, usando la cenere quale organico pigmento e la visione non offuscata dei puri quale ex machina ispiratore. Per ereditare e tramandare ancora una volta e ciclicamente quel disegno. E sono proprio gli affreschi intravisti nel corso di “Midsommar” (e l’arazzo stesso con cui si apre il film) a restituirci figurativamente una storia già nota e a rendere metaforicamente già edotto lo spettatore circa la parabola che seguirà. E’ tutto già scritto sembra dirci Aster, come in ogni folk-horror che si rispetti o come nelle fabule crudeli e ricorsive. Ma in realtà di questi racconti conosciamo solo lo scopo ma non il modo. Ed è proprio quest’ultimo invece a schiudere lungo la narrazione di Midsommar insoliti squarci psicologici sui due protagonisti, meno distanti da noi di quanto possiamo credere. Sono squarci borghesi che fanno vibrare dentro quella coppia risonanze che in fondo ci appartengono. Portatrici di verità che rifiutiamo e che, inevitabilmente, ci spaventano. Anche più dell’horror stesso.
Andrea Lupo



























Commenti recenti