

Accantoniamo i “crepuscolare” e i “capolavoro” per una volta. Teniamoci a debita distanza dai primi, abusati significanti critici buoni per chi sta per dipartire cinematograficamente (vedi Clint Eastwood, “certificato” crepuscolare già da “Gli spietati” e capace di infilare da allora almeno altri sette-otto capolavori non crepuscolari), ed evitiamo saggiamente pure i secondi, solenni e gratuiti strilloni in uso ai multisala. Soffermiamoci invece sul maestro (che di sublime arte ne firmerà ancora) e soprattutto sull’uomo Scorsese, quel cineasta che da mezzo secolo dialoga incessantemente con se stesso attraverso la celluloide e il digitale, la memoria e il presente e oggi pure coi provider televisivi multimiliardari e la de-aging technology. Martin che dialoga col proprio sé (cinematografico) attraverso il cinema mentre il cinema lo ri-crea ancora e sempre maestosamente solo per i nostri occhi. E questo nonostante l’industria hollywoodiana – quella che lui, insieme a una magnifica sporca dozzina di registi, ha contribuito a far grande più che ricca -gli abbia voltato sdegnosamente le spalle, costringendolo ad alleanze fino a pochi anni fa impensabili (il fortilizio Netflix). Non importa a questo punto come The Irishman sia nato, importa solo che sia nato. Che sia stato dato al pubblico e a un suo pubblico. Che Scorsese abbia potuto proseguire quel meraviglioso dialogo coi fantasmi del suo cinema invece di soccombere, come purtroppo tanti autori, al ben più spaventoso spettro del progetto irrisolto. E veniamo al film, che dopo la fluviale e impegnativa visione non posso ammettere di aver amato più di “Casinò” o “L’età dell’innocenza” (qui citati per speculazione). In quei due titoli l’impeto narrativo di Scorsese diveniva sinuoso movimento visivo, musicale e psicologico, l’arte trascendeva mezzi (e vezzi) tecnici e il cinema finiva per tracimare fuori dal suo stesso cinemascope. Due meravigliose pellicole che non sono semplicemente innervate nella corteccia sensoriale del cinefilo (e specificamente del sottoscritto), ma che parlano dello stesso processo creativo del cineasta italo-americano, non fosse altro perché, messe a confronto, paion quasi opere speculari e consequenziali. Speculari perché l’affresco su una consorteria silenziosa (la nobile società americana di inizio ‘900) che cesella i propri atti di violenza negli ori e nei marmi non era dissimile dal ritratto della mafia di Las Vegas con la sua filiera vorace di dollari e anime (con quest’ultima impegnata a nascondere i corpi nel deserto laddove la prima li desertifica dentro abiti da teatro). Conseguenti perchè quando Scorsese dopo Edith Wharton adattava nuovamente Nicholas Pileggi, più che all’amorale e irresistibile ascesa dei goodfellas guardava ancora all’impossibile legame fra la contessa Olenska e l’avvocato Archer. E così se era facile individuare in “Casinò” la chiusura di un’ideale trilogia gangster dopo “Mean Streets” e “Quei bravi ragazzi”, più sottile era scorgere nel logorante e masochistico rapporto fra Asso Rothstein e la tossica Ginger i residui dolorosi del precedente melò di stampo viscontiano.


Quelle pellicole testimoniano che nella filmografia di Scorsese persiste sempre un dialogo vivo e coerente tra l’uomo e il cineasta, un dialogo intessuto di suggestioni sospese fra il personale e il cinefilo, che travalica piani predefiniti (non c’è mai stata nessuna trilogia o tetralogia gangster, neppure dopo The Irishman) e si affida unicamente alla brama di raccontarsi e ancor più del raccontare. Frammenti biografici (Little Italy ma non solo) sparsi però anche nella letteratura, nei generi praticati e con quest’ultimo film anche dentro la Storia, quella a stelle e strisce che brucia fra le intercapedini di un sorvegliato e anti-spettacolare gangster-movie. The Irishman dunque non è l’epilogo senile di un discorso iniziato fra i ghetti di Mean Streets ma, come dimostrano i sopracitati legami fra “Casinò” e “L’età dell’innocenza”, ancora una volta il risultato di un germogliare antecedente e soprattutto il perfezionamento e la prosecuzione di una riflessione mai interrotta del suo regista. E pur ribadendo di non aver amato “The Irishman” più di “Casinò” o “L’età dell’innocenza” me ne sono innamorato proprio per queste ragioni. Più che dal mafia-movie l’ultimo lavoro del regista sembra discendere allora dall’austera e luttuosa consapevolezza che permeava il precedente film, il dolente e bellissimo “Silence”. Da quello infatti proviene il rigore che informa l’epica in sottrazione di questo “irlandese”, opera solo in apparenza subordinata ai codici espressivi della sua destinazione (televisiva), ma che in realtà attraverso la dilatazione del racconto intende rielaborare nuovamente (scorsesianamente) lo stesso tempo cinematografico.


Sottostimato e potentissimo “Silence” affrontava di petto con lucidità e controllo esemplare dell’inquadratura uno dei temi più cari allo Scorsese-uomo, quello della fede, già fermamente saldato alla sua filmografia e, al di là de “L’ultima tentazione di Cristo” e “Kundun”, continuamente evocato anche solo visivamente in ogni suo racconto di violenza metropolitana (i fasci di luce impossibili che penetrano nel buio, le visioni dall’alto). Il capitolo storico e scomodo sul Giappone evangelizzato e l’indagine interna sul sentire cristiano venivano a raccordarsi in quel film sul medesimo binario formale, su una prospettiva paesaggistica che diventava istintivamente ideologica (perchè frontale e quindi diretta, schietta), mentre storia e riflessione si suturavano fra loro per mezzo di contrasti visivi densi ed eloquenti: le nebbie che avvolgono la fede, la dialettica fra apostasia – tersa e colta- e virtù-sudicia e modesta, le disarmonie fra dogma e azione. In “Silence” non c’è una preghiera che appartenga ai vincitori o ai vinti, né solo ai martiri convertiti o ai gesuiti abiuranti. Appartiene semplicemente ai testimoni, silenti almeno quanto il loro Dio. E’ un’orazione aperta, mai risolta. Non è definitiva insomma, proprio come la morte che uno stanco e disilluso Frank Sheeran-De Niro insegue nel finale di The Irishman, quando la cerca dentro una bara scelta da vivo, in un loculo piuttosto che nella cremazione (perché cattolicamente la sepoltura non è un rito conclusivo), su una porta lasciata socchiusa o ai bordi di uno schermo sul quale indugia dolorosamente insieme a noi. E il tempo, quel tempo che Scorsese attraversa con generosità e che accarezza malinconicamente sopra ogni ruga dei suoi splendidi protagonisti, è forse l’unico, vero e più taciturno sicario dell’intera vicenda. Uno di quelli che non ha bisogno di scegliere la pistola giusta per pianificare l’omicidio di turno perchè l’attesa è già l’unica e più letale munizione. The Irishman, per quanto dialogatissimo nel suo serrato confronto fra caratteri, proviene dunque da quel silenzio che l’ha preceduto cinematograficamente e, come già “Silence”, mette in scena una dialettica fra dimensioni, non religiose e storico-culturali bensì politiche e criminali, in evidente antinomia fra loro (sindacalisti e gioco d’azzardo, sicari e democrazia, mafia e famiglia). Al di là del viaggio a ritroso nella memoria del protagonista, che naviga dentro di sè come dentro la Storia Americana, tra l’ingombro delle icone (JFK) e le ombre umane che le inseguirono, oltre l’intreccio fra mafia (Sheeran, Bufalino) e politica (Hoffa), il sentimento che domina in The Irishman è allora quello dell’ inconciliabilità, di una convergenza forzata fra differenti identità (americane, irlandesi, italiane come in “Gangs of New York”) e ambienti (quello familiare e l’altro criminale) felicemente conviventi solo in apparenza.


Ed è proprio il tema familiare quello che permea silenziosamente l’intero arco narrativo di The Irishman, a partire dal prologo nella casa di riposo (col gangster in carrozzella che proviene direttamente dal finale di “Casinò”, immagine che ritorna nel finale ma riempita di altro senso) fino al viaggio in macchina con le manie del boss Bufalino a fare da affettuosa cornice. E se i viaggi, i riti delle festività e quello ricorrente del pane inzuppato nel vino sembrano comporre il quadro di una familiarità alternativa basata sull’amicizia (d’onore), dietro le quinte affettive della famiglia vera brulicano invece le nevrosi, il distacco e un progressivo disamore. Scorsese dirige con maestria il confronto fra caratteri e lascia che la Storia (quella americana) si faccia largo tra di loro e nella memoria di chi resta (chi ricorda più Jimmy Hoffa?) slegando il suo stesso tempo cinematografico dai ritmi nervosi del passato. Tuttavia è sul cuore spezzato di un nucleo che posa ciclicamente e pudicamente il suo sguardo, sul deterioramento di una tenerezza e l’irreversibilità di un sentimento. Così è a quelle brevi sequenze silenziose collocate come segni di interpunzione fra un atto e l’altro del film, che il regista si affida per far montare il conto salato e doloroso di Frank, probabilmente il più amaro fra quelli riservati ai gangster sopravvissuti del suo cinema. La fede di Silence come l’amore familiare di The Irishman, entrambi feriti da scelte unicamente umane. Ma se il silenzio di Dio poteva essere comunque indizio di una preghiera sempre aperta e di un dialogo non reciso (il crocifisso che brucia nelle mani di Padre Rodrigues), l’oblio sulla terra invece è già diventato sentenza inappellabile, atto spaventosamente conclusivo e perfino terminale. Per questo occorre lasciarsi dietro una porta socchiusa. E che qualcuno guardi dentro quella fessura affinchè il crepuscolo non divenga mai realmente definitivo.
Raramente Scorsese ci aveva voluti così vicini a sè. Mai il suo cinema era stato tanto straziante.
Andrea Lupo

























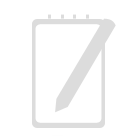

Commenti recenti