
Seconda parte dell’articolo sui 40 film da ricordare del 2019. Anche qui nessuna ideale classifica (il n. 40 non è meno importante dei precedenti) ma solo un’elencazione dettata dalla memoria, dall’emotività, dalle connessioni instauratesi nella mente mentre rievocavo le visioni avute nel corso dell’anno. Consapevole della incompletezza di ogni lista (come al solito sono state tante le visioni perdute) vi offro comunque un piccolo compendio ragionato di scelte (ovviamente personali).
Giusto per dimostrarvi che i bei film, nonostante tutto al cinema sembri essere stato già raccontato, esistono ancora e sono molti.
Soltanto bisogna avere voglia di inseguirli.
O magari di farsi trovare da loro.
Buona lettura!

21.The Mule-Il corriere. Clint Eastwood e l’elegia di una vecchiaia che non si arrende? Forse. Ma The Mule è molto di più. Non tanto un film che riflette sull’età quanto sul tempo, quello che spendiamo (male) e doniamo (indegnamente). Quello che un floricoltore in pensione si reinventa nella sua terza età come corriere della droga. Uno che non mette fretta alle sue consegne proprio come ai fiori che coltiva. Tempo che tra una consegna e l’altra il corriere ha perfino il coraggio di mettere in pausa, per ritrovare un po’ di vita nella morte. Poesia delle rughe, classicissima e perfetta come sempre. Clint non si discute. Si vive e basta.

22.La douleur. Privazione, dolore, attesa. E la memoria naturalmente. Quando il cinema si misura con temi e storie così profondi (e adatta autori di peso come Marguerite Duras) il rischio di inciampare nel romanzo rosa e in certe sue derive calligrafiche è piuttosto alto. Non accade per La douleur che invece affronta quei diversi strati narrativi col passo bruciante del melò, chiave di volta della materia e collante fra indagine storica ed esplorazione psicologica. L’equilibrio è affare delicatissimo al cinema e in tal senso il film si dimostra esemplare. Un apologo sull’afflizione come male necessario per (soprav)vivere, segnato dallo sguardo desolato e insieme desiderante della Thierry.

23.La mia vita con John F. Donovan. Xavier Dolan, osannnato dagli americani quando gira i suoi film francesi (Laurence Anyways, Mommy), viene massacrato dagli europei quando ne gira uno americano con la medesima visione. Incongruenze di una critica che non sa (più bene) cosa dire ma continua a farlo. A scanso di equivoci invece il film è bello e toccante. Meno segnante dei precedenti ma coerente con quel percorso d’autore a cavallo fra biografismo, estetica pop (alta) e mappatura del desiderio. Cinema che non lascia mai personaggi sullo sfondo ma regala a ciascuno il proprio momento di gloria e di passione. Ruolo amaro costruito perfettamente sull’espressione melanconica del Kit Harington del Trono di spade.

24.Il gioco delle coppie. Se si sorvola sull’orrida traduzione italiana che riduce la finezza del copione francese a un programma tv e ci si concentra invece su quelli originali, Doubles Vies o Non-Fiction, si potrà avere un’idea più esatta dei temi intorno ai quali ruota quest’ultimo film di Olivier Assayas (Sils Maria, Personal Shopper). Che ha ovviamente al suo centro la coppia, anzi tante coppie che si scompongono e ricompongono secondo le tipiche coreografie del sentimento. Ma il regista dà convegno a suggestioni ancor più moderne come quelle legate all’editoria e alla moderna fruizione culturale, anch’essa sull’orlo di una doppia vita (come quella dei protagonisti). Fra la coppia analogica e quella e-reader non è facile scegliere. Non ci resta che parlarne (e riderne).

25.Il primo Re. Terrigno, oscuro e assai ambizioso. Romolo e Remo secondo Matteo Rovere in un’unica, lunghissima notte prima del giorno nell’anno Urbis conditae. Una sfida la sua (il film è tutto recitato in proto-latino per evitare ogni caduta nell’accento romanesco), di quelle che dovrebbero essere osate più spesso da parte dei nostri registi. Il moderato successo di pubblico (che si lamenta sempre della poca originalità del cinema italiano) dimostra invece la diffusa pigrizia popolare nel comprenderla come operazione necessaria. Volti perfetti (Borghi, Lapice ma anche gli altri), magnifica fotografia notturna e infuocata firmata non a caso da Daniele Ciprì.

26.Un giorno di pioggia a New York. La levità della pioggia che bagna il classico girotondo alleniano dei sentimenti. Solo Woody è capace di rendere plausibili su schermo certe contorsioni del cuore che altrove sarebbero forzate o posticce. In 92 umidi e caldi minuti c’è posto pure per la cinefilia, l’equivoco, i musei e una rivelazione familiare dolce e scioccante insieme. Il suo ultimo film prima dell’isterica invettiva #metoo è una sorta di “Fuori orario” baciato dal sole del tramonto e soavemente minacciato da una perturbazione che si chiama amore. Ma chi l’ama più New York come lui?

27. Il signor diavolo. Ciclicamente ritorna l’horror anche per Pupi Avati. E ancora una volta il maestro bolognese ci riconcilia con tutto ciò che credevamo di aver perduto nel genere (almeno in Italia). Una narrazione lenta e insinuante, un senso autentico del macabro, l’angoscia tangibile dei luoghi (ma anche il loro ricordo affettuoso) e quella cappa religiosa opprimente e muffita che avvolge tutto e governa le azioni una volta ancora dal basso. Tanti volti noti e ben ritrovati al suo servizio, una Chiara Caselli sensualmente malconcia e un protagonista, l’ottimo Gabriel Lo Giudice, ancora più angelicato che nel romanzo. Da vedere per comprendere quanti danni silenziosi il teen-horror ha prodotto nella fruizione del genere.

28. Una notte di 12 anni. I film di denuncia, quando sono realizzati bene, possono fare male, molto male. E quello di Alvaro Brechner colpisce giù duro con la sua storia di disumana prigionia dei tupamaros scontata al tempo della dittatura in Uruguay negli anni ’70. Si filma dentro le prigioni, si vive nel buio insieme ai protagonisti, in mezzo al tormento delle loro privazioni (di diritti civili e naturali). Si soffre, perché se non si prova quella sofferenza è come se non fosse mai vissuta.

29. Se la strada potesse parlare. Storia di passione, razzismo, errori (ma soprattutto orrori) giudiziari dal regista di Moonlight. Due livelli temporali che si attraversano fra loro per raccontare da un lato quei corpi che si bramano e dall’altro l’ingiustizia sociale che li avvolge e separa. La fotografia accarezza le epidermidi degli amanti e fa l’amore con loro, consegnando l’intimità a quel confessore silenzioso che è la strada. La purezza del sentimento così rappresentato bilancia l’atmosfera guasta e intollerante del tempo. E vince sullo schermo. Ammaliante.

30. Ad astra. L’escursione della fantascienza firmata James Gray non inventa nulla di nuovo; la precisazione è solo per quelli che cercano i 2001 negli Interstellar e odiano gli Interstellar dentro altri film. Ma il regista filma con l’occhio puro di chi scopre queste storie per la prima volta e solo per questa ragione andrebbe difeso. Perchè alla fine è proprio quello sguardo a svelare approcci emotivi inediti e, cosa rara, a regalarci visioni avveneristiche sorprendenti e maestose. Il viaggio di Brad Pitt non si dimentica e probabilmente vale più della sua ridondante seduta di autocoscienza. Alla finale resa dei conti dei sentimenti però il pubblico storce il naso. Peccato, perchè ogni incontro cinematografico con il padre tra le stelle, oltre a restare metafora potente, sa essere sempre prepotentemente toccante.

31. Copia originale. Piccoli film forse, ma di quelli che sanno raccontare benissimo le miserie di grandi personaggi. Come quelle di Lee Israel (una splendida Melissa McCarthy) biografa caduta in disgrazia (al limite della topaia per intenderci) e capace poi di risorgere scrittrice grazie a una bizarra opera di falsificazione. L’originale truffa a base dei non originali di lettere famose la rese ricca solo per un po’ (prima dell’ inevitabile imputazione e del successivo processo) ma inaspettatamente vera. Piccoli film di quelli che ci fanno toccare con mano solitudini distanti, grazie magari alla compassionevole presenza di un gatto o al calore di un fragile amico reietto. La tenerezza, senza sconti sul dolore, passa anche da qui.

32.Border-Creature di confine. Creature di confine e cinema di confine quello di Border. Il fantastico nord-europeo di creature immaginifiche innestate in un contesto urbano e moderno dove le stesse vivono integrate e apparentemente consapevoli. In realtà il film è un viaggio attraverso una ferinità negata, imbrigliata nei ruoli sociali e pronta ad esplodere e a rovesciare schemi precostituiti sulla base di una diversa e ineluttabile geografia sessuale. Insolito, incisivo e mutaforma almeno quanto i suoi due protagonisti, bravissimi anche nascosti sotto un trucco che li rende irriconoscibili.

33.Boy erased- Vite cancellate. Un horror mascherato da psico-dramma familiare che racconta l’odissea di giovani ragazzi costretti a sottoporsi a un programma cristiano di recupero per reprimere le naturali pulsioni omosessuali. Pratiche bandite progressivamente anche da alcuni stati Usa ma mai veramente debellate nel resto nel mondo. Joel Edgerton al secondo film non ha ancora maturato una sua peculiare personalità registica. Tuttavia la scelta del tema (dopo il bullismo di Regali da uno sconosciuto) rimane encomiabile almeno quanto quella delle due star coinvolte (Kidman e Crowe), qui al servizio della causa attraverso personaggi sgradevoli, sofferti e diversamente ambigui. Un film purtroppo poco visto ma attuale e necessario.

34.Cafarnao-Caos e miracoli. L’odissea del piccolo Zain che non si arrende alla miseria libanese e chiama i genitori in giudizio con la singolare accusa di averlo messo al mondo. Attraverso il processo e un classicissimo flashback scopriremo i diversi perché e comprenderemo le ragioni di questo bimbo imbronciato, piombato nel caos di una Beirut-Cafarnao nuovamente abbandonata dopo i miracoli. La rappresentazione della miseria è palpabile, per qualcuno facile e ricattatoria, ma importa poco. Perché se c’è un miracolo in questo film della sensibile Nadine Labaki è quello di corroborarci di vita nonostante il dedalo di situazioni sempre più strazianti. E mentre il piccolo Zain nell’ultima sequenza finalmente si concede a una risata a noi inaspettatamente esce la lacrima fin lì trattenuta.
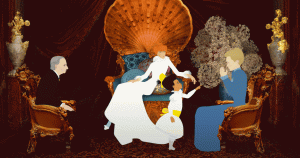
35.Dilili a Parigi. La soavità del tratto, l’intelligenza della scrittura, il potere dell’ironia e la forza salvifica delle arti umanistiche. Forse il più bel cartone dell’anno. La Belle Epoque di Michel Ocelot (Kirikù e la strega Karabà, Azur e Asmar) è un universo multirazziale ad altezza di bambina dove i protagonisti della cultura (letteratura, pittura e scienza) diventano i complici silenziosi di una storia (cupa) fatta di rapimenti, sottomissione e orribili strutture patriarcali. Vince Dililì naturalmente (anche se Marie Curie, Toulouse-Lautrec e Gustave Eiffel le danno una mano), ma alla fine vincono anche la tolleranza e soprattutto l’arte. Una delizia per gli occhi e per la mente.

36.The nest- il nido. Altro azzardo italiano vinto su quasi tutta la linea. Dico quasi solo perché il film, diretto con notevole mestiere (ed è un’opera prima) è assai ben bilanciato nelle atmosfere, sorretto da un cast in parte e fotografato meravigliosamente. Il problema (ma è una percezione soggettiva) sta forse nella rappresentazione di quel twist finale, sorprendente certo ma anche troppo debitore di visioni (televisive e cinematografiche) già note. E’ l’unico elemento dissonante dentro una narrazione fin lì misterica e affascinante. Ma a parte questo neo di pochissimi secondi (che tuttavia non ha disturbato altri) un film e un regista, Roberto De Feo, da difendere e sostenere con le unghie.

37.L’uomo nel labirinto. Donato Carrisi alla sua seconda prova registica dimostra di avere idee cinematografiche abbastanza chiare e audaci. Non gli basta infatti trasporre semplicemente l’omonimo suo romanzo su grande schermo mantenendone struttura e sviluppi, ma decide di annegare la vicenda dentro ambienti e paesaggi malsani, simbolici (quei roghi vagamente apocalittici) e metaforicamente fuori dal tempo (il kafkiano ufficio delle persone scomparse). Derivativi magari ma non per questo meno efficaci dei modelli di riferimento. In più riesce a contenere entro misura i debordanti talenti degli attori a sua disposizione (qui Hoffman e Servillo). Mica poco.

38.Pinocchio. Attesissimo dagli estimatori di Garrone (e di Collodi), Pinocchio rimane archetipo italiano non solo dell’infanzia (cristallizzata in una visione rurale, severa e insieme astorica) ma anche delle metamorfosi cui va incontro l’essere umano. L’immaginario del romanzo è trattato con devozione dal regista di Dogman. Garrone dà il meglio del suo mestiere sia quando si incolla ai volti antropomorfi del diverso bestiario favolistico (il giudice, il grillo, la chioccia) che quando impagina scenari petrosi e realistici (Il racconto dei racconti docet). Spiace tuttavia che dalla rappresentazione siano stati tenuti fuori gli elementi più funerei (la morte della fatina, la fine di Lucignolo) sui quali la versione di Comencini indugiava con didattica mestizia. Forse un problema di sintesi necessaria o di compromessi produttivi. Tuttavia riuscire a tirar fuori un Pinocchio classico (dopo un secolo di riletture) facendo innamorare nuovamente un pubblico non è da tutti.

39.Knives Out- Cena con delitto. Più che un whodunit (letteralmente “chi l’ha fatto?”, cioè la sintesi del giallo) un who is who do it (“chi è chi l’ha fatto?”, che suona un po’ come lo studio di caratteri dietro). Rian Johnson, regista di Looper e del miglior Star Wars della saga recente (“Gli ultimi Jedi”), mette il suo estro al servizio di un mistery in cui si sa cosa è successo più o meno a metà narrazione. Forse. L’intreccio noir regge benissimo, lo spaccato sociale (alto-borghese) è servito con la giusta perfidia e i caratteri in scena definiscono ben più di un’ossessione personale buona giusto per un movente. Frecciate politiche (anti-Trump? )non da poco. Gustosissimo.

40. Storia di un matrimonio. L’anno di Netflix (e del cinema soprattutto) si chiude con uno dei suoi film più amari e belli. Noah Baumbach piazza una sonda dentro le faglie di una coppia al capolinea (Driver e Johansson, meravigliosi) e radiografa due blocchi che, nonostante le recriminazioni (orali ma non scritte), gli avvocati (straordinaria la Dern) e i rimbalzi delle rispettive insofferenze, stentano a staccarsi di netto. Il crepaccio c’è insomma ma non lo vediamo mai. Paradossalmente viviamo con loro la tenerezza dei piccoli gesti, il quotidiano divergente sul figlio, l’affiatamento residuo. Viviamo insomma quell’amore che non viene meno neppure in un divorzio non più rimandabile. E anche se le loro rivendicazioni sono una rappresentazione bifronte dello stesso bisogno, si assiste desolati e rassegnati a quell’inevitabile così tanto ricorrente. Mai separazione è stata accompagnata al cinema da tanto amore.
Andrea Lupo



























Commenti recenti