
E’ stato un bell’anno cinematografico quello appena concluso. I miei motivi saranno magari diversi da quelli di tanti altri. C’è chi si è commosso con il finale di “Avengers Endgame” e chi riattraversando la savana realistica del “Re Leone“, chi attendeva trepidante il finale di “Star Wars Episodio IX” e chi non vedeva l’ora di ripercorrere i corridoi del’Overlook Hotel in “Doctor Sleep“, chi si immergeva in una Downton Abbey finalmente panoramica e chi, più piccino, voleva tornare ad Arendelle per riabbracciare Elsa e Anna (Frozen 2) o nel mondo dei giocattoli (Toy Story 4).
I motivi per godere del cinema sono tanti, tutti diversi, moltissimi validi.
Qui elenco film e motivi per i quali è stato bello continuare ad andare al cinema durante il 2019. Ci sono anche titoli assenti ma ugualmente visti e apprezzati (Dumbo il live-action Disney meno assoggettato, Yesterday), alcuni titoli perduti (tanto cinema d’autore inseguito o mai arrivato come Vox Lux e Tramonto) e altri autori ancora da recuperare (La vita invisibile di Euridice Gusmao, Burning). Non è una classifica (l’ordine in cui appaiono è casualmente emotivo) ma un’elencazione di tutto quel “meglio” che ho voluto rievocare, magari risarcendo idealmente quei titoli che avrei voluto, ma non ho potuto, recensire più approfonditamente.
Sono 40 titoli che ho diviso, per comodità di lettura, in due parti. A voi la prima, forse la più circostanziata e critica, fatta di quel meglio che mi è immediatamente venuto in mente quando ho iniziato a stendere questo personale elenco. Magari qualcuno fra questi titoli lo recupererete nel tempo pensando a me.
Buona lettura e buon cinema sempre. Perchè ci sono almeno 2020 motivi per continuarlo ad amare…
Andrea Lupo

1.Suspiria. L’attesissimo e discusso remake del cult argentiano è un’opera dotta, stratificata ed ambiziosa, splendidamente immersa nella coltre politica ed esoterica degli anni ‘70 tedeschi (laddove Argento di quegli anni interpretava gli sperimentalismi psichedelici per poi introiettarli nella fiaba). Una narrazione che inghiotte fino alla fine dei suoi foschi, mefitici 152 minuti, una sequenza di danza-morte scioccante e un sabba grottesco e cromaticamente spinto poco prima dell’alba. Guadagnino demitizza la stessa mater(ia) stregonesca per arrivare alla memoria storica, portando nuovamente alla luce, dopo “Chiamami col tuo nome”, le ragioni del sentimento.

2.La favorita. Nobildonne sull’orlo di una crisi di nervi nell’Inghilterra del 1700. Scene di lotta di classe dentro e fuori la corte della regina Anna i cui favori sono contesi da due aspiranti favorite, cugine disposte a spostare sempre più in basso l’asticella dell’antagonismo. Fra spruzzi di fango e pulsioni saffiche si consuma un minuetto impietoso dove gli uomini, quando non manovrano (manovrati a loro volta), sono assai meno significativi dei 17 dolorosi conigli della regina. Cast femminile di primo livello e Oscar, meritatissimo, a Olivia Colman. Ha oscurato l’altro film storico del periodo, “Maria regina di Scozia”, più morigerato ma anch’esso femminista e bello.

3.Rocketman. Il finale de “La favorita” con la splendida Skyline Pidgeon eseguita al clavicembalo sembrava anticipare che il 2019 sarebbe stato l’anno di Elton John, dopo quello tutto bohemian di Freddie Mercury. A unire i due biopic lo stesso regista – chiamato a completare il film sui Queen e a girare interamente questo- ma non la medesima idea di film musicale. Rocketman cavalca la biografia (re-immaginata), si concede inaspettatamente al musical e al suo onirismo ed è decisamente più queer e audace di Bohemian Rhapsody. Taron Egerton, bravissimo, si ritaglia uno dei ruoli della vita. Il film, anche senza un successo da stadio, resta uno dei più freschi e piacevoli dell’anno.
![]()

4.L’ufficiale e la spia. Polanski posa lo sguardo sopra il terreno (minato) del perseguitato processuale, portando sullo schermo il j’accuse di tutti i j’accuse, il caso Dreyfus. Una scelta interpretata come biografica dai critici di ogni latitudine (Polansky come Alfred Dreyfus per quel calvario infinito intorno alle accuse di violenza sessuale) ma in realtà molto più motivata sotto il puro profilo cinematografico. Perché il balletto delle scrivanie e delle scartoffie rivelatrici filmato con rigore storico e rara perfezione visiva, è molto più vicino ai riverberi kafkiani e paranoici della sua filmografia che alla (facile) sovrimpressione morale fra autore e personaggio storico. L’attualità c’è naturalmente ed è quella degli antisemitismi di cui geneticamente e ciclicamente ogni società pare avere ancora un irrazionale, devastante bisogno. Una lezione di cinema maiuscola.

5.Joker. Non si potrà parlare del 2019 senza parlare di Joker. Ma il Leone d’oro di Venezia 76 appartiene più a Joaquin Phoenix che al regista Todd Phillips. Il quale, beninteso, gira un film notevole, a tratti potente (il finale è un crescendo memorabile), nobilmente debitore degli anni ’70 (gli omaggi a Scorsese, la grana fotografica). Ma anche un titolo che passerà alla storia più per il portato socio-politico del suo (casuale) vilain che per i meriti di sceneggiatura (eccessivamente addentrata nella visione vittimistica e nei tortuosi psicologismi del suo clown). Siamo tutti Joker, si declama nel caos stordente alla fine del film. Più probabilmente siamo tutti in cerca di un joker dentro il quale far confluire ogni singola frustrazione, personale, sociale, economica e perfino culturale. Il senso e i le ragioni dell’enorme successo stanno anche qui. Il male puro però viene espunto ancora una volta dalla moderna narrazione hollywoodiana, più giustificazionista che coraggiosa.

6.Parasite. La Palma d’oro di Cannes di quest’anno ha messo d’accordo tutti ed ha performato benissimo perfino al botteghino americano. Bong Joon-Ho piega le regole dell’intrattenimento di genere che conosce bene (The Host, Snowpiercer, Okja) a quelle dello spaccato sociale ed economico del Terzo millennio. Ne viene fuori un’opera che fa dell’architettura (la villa, la baracca, lo scantinato) metafora lineare sul classismo privo di cuscinetti sociali (e morali). Il parassita del titolo alla fine è un testimone che passa disinvoltamente in mano ad ogni singolo personaggio poco prima della deflagrazione e dell’alluvione. Alla fine residuano solo i fantasmi del sentimento, non del tutto contaminati. Un moderno Bunuel riletto dalla generazione delle app e del wi-fi, sicuro (e meritato) protagonista agli Oscar 2020.

7.Ritratto della giovane in fiamme. Uno dei film più avvolgenti e vibranti dell’anno. Un superbo, pittorico melodramma femminile (e fieramente femminista) che mette in scena il dualismo del sentimento. E’ meglio amare pienamente o affidarsi alla poesia del rimpianto? Precedere Euridice fino alle soglie dell’Ade o voltarsi come fa Orfeo rinunciando definitivamente all’amore? Trionfa il simulacro, la pura contemplazione, l’immagine da custodire nell’anima. Trionfa semplicemente il cinema. Il mito delle Georgiche trova linfa, significato e nuova sensualità in questa storia d’amore ambientata nel ‘700 su un’isola al largo dalle convenzioni. Squarci onirici che paiono dipinti, due protagoniste magnifiche e tempere che fissano gli istanti, i sussulti e le fiamme. Indimenticabile.

8.C’era una volta a Hollywood. Il nuovo Tarantino, quello che non rifà (più) scopertamente se stesso ma si rigenera dentro tempi più dilatati, fra le pieghe caratteriali dei personaggi (non pulp ma “polposi”), penetrando i generi con meno filologia maniacale e più amore. Il film è sì quel piccolo-grande compendio su un frammento specifico di Hollywood che promette il titolo, con azzardi metaforici e palesi dicotomie (il divo scolorito e la sua ombra stuntmen con spessore, la storia vera e la riscrittura emotiva sopra la stessa) ma è anche il gesto consapevole di un cineasta che ha abbandonato -a proprio rischio- uno stile per sposare un’idea di regia meno condiscendente e più emozionante. Alzi la mano chi non si è commosso vedendo Margot Robbie-Sharon Tate che si emoziona (a sua volta) riguardandosi su grande schermo…

9.Martin Eden. Un azzardo tutto italiano. Talmente azzardato come progetto da far pensare -pregiudizialmente- che dietro non ci sia neppure un regista italiano. Invece l’idea di trasporre il romanzo di Jack London in un contesto napoletano, temporalmente significativo (presumibilmente dal secondo dopoguerra agli anni ’80) e tale da generare, fra vere immagini di repertorio e moderno neorealismo visivo, nuove sollecitazioni intellettuali oltre che letterarie, è di quelle che il nostro cinema dovrebbe prendere ad esempio per alimentare il proprio rinnovamento (Pietro Marcello nel 2019 è un po’ come la Rohrwacher di “Lazzaro Felice” nel 2018). Toccante, problematico e colto ma mai superbo o distaccato dal pubblico. Che infatti l’ha premiato con un incasso (1,8 milioni di euro) di questi tempi impensabile.

10.Il traditore. Un film con tante anime, tutte però perfettamente riconducibili allo spirito del suo magnifico regista. Dal gangster-movie (l’incipit è incalzante e potente) al mafia-movie (con quei taglienti spaccati caratteriali sulle icone della passata cronaca italiana), passando per il grottesco (il maxi-processo), l’onirico (la bara di Buscetta) e il metaforico (la scioccante sequenza in elicottero che genera dubbio e spaesamento in ogni spettatore). Bellocchio si adegua, come necessario, alla complessità della materia e del personaggio e si fa, giocoforza, autore popolare (nell’accezione positiva del termine). Il suo cinema anche qui rimane grande, magmatico ed evocativo (il miglior utilizzo del “Va’ pensiero” su una sequenza, dopo “Inferno” di Dario Argento, è qui). Per Favino, Ferracane e Lo Cascio solo lodi.

11.Dolor y gloria. L’Almodovar della maturità, quello che riflette sopra i temi della malattia (e dell’ipocondria), sull’amore e sul sesso, sulle proprie origini di cineasta e sulle ragioni dell’essere narratore oggi. Lo schermo è ancora lo specchio dell’anima del regista ma stavolta ne restituisce non tanto l’immagine attuale quanto una differente e più auspicabile proiezione. E in questo raccontare e raccontarsi il regista spagnolo si reinventa (grande) dinanzi al suo pubblico. E quello schermo non è più parete ma alberi infiniti, come recita “Il cielo in una stanza” qui usato quale leit-motiv della memoria. Inevitabile che un simile alter-ego fosse interpretato proprio da Antonio Banderas, mai così bravo e anche lui in odore di Oscar insieme al film.

12.Midsommar. Il folk-horror secondo Ari Aster è una salmodiante e soleggiata ricognizione dentro i territori dannati di Harga ( immaginaria e reale insieme) fra cerimoniali pagani, trip acidi e pire celtiche. Ma per quanto lambito non è il modello di “Wicker Man” l’obiettivo di questa impeccabile opera seconda del regista di Hereditary. “Midsommar” infatti non si accosta al male per farne il rigurgito ritualizzato e separato di una comunità ancestrale in opposizione alla civiltà, ma ne fa il rifugio emotivo di una personalità scossa e alterata che vi sprofonda dentro con convinzione. A bruciare in primo luogo v’è la cellula di un’ istituzione occidentale (la coppia moderna) già fallita. Consapevolezza e follia alla fine si confondono ed è questo che fa veramente più paura.

13.Mademoiselle. Un intruso (è un film del 2016) che va menzionato non solo perché uscito qui in Italia solo quest’anno ma anche perchè tra i film più seduttivi e narrativamente sinuosi visti su schermo. Un palindromo erotico che cambia continuamente di senso e si diverte a interscambiare i ruoli (e i rapporti di potere) delle sue protagoniste (e protagonisti) come un teatrale kamasutra . Park Chan-wook (Old Boy, Lady Vendetta, Stoker) filma idealmente le pagine di un manuale coreano sul sesso mai pubblicato e dopo averle vergate con qualche spruzzata di sangue si diverte a stracciarcele in faccia. Il maschio- depotenziato e castrato- può solo assistere impotente alla scena. Elegantissimo e sfacciato.

14.La casa di Jack. Von Trier o Dell’importanza di essere killer. Dei generi, dell’ordine costituito e del cinema tutto. Di serial nel suo cinema amato/odiato c’è soprattutto la volontà di non schierarsi mai, neppure moralmente dinanzi alle gesta di uno psicopatico ossessionato dal metodo e dall’ordine. La casa che Jack costruisce è fatta di corpi macellati certo ma è anche un architrave che regge ogni possibile sistema, da quello familiare a quello divino. Ordini e cattedrali destinati a crollare sotto il peso dell’instabilità umana. Quelli che resistono invece sono i pilastri del suo cinema, talmente saldi da contenere ogni possibile (forma di) riflessione. Un film lucidissimo e debordante.

15.The Irishman. Uno dei film più funerei e laceranti di Scorsese è, ancora una volta, mascherato da gangster movie e attraversato dai fantasmi delle sue vecchie icone (ma c’è anche la novità Pacino qui per la prima volta al servizio del regista). Una storia americana rivolta non ai soli americani ma a chi la storia la sta già dimenticando (o non l’ha mai vissuta). Un atto dovuto di cinema fatto da chi il cinema lo vive visceralmente. Un grandissimo affresco sulla memoria individuale, politica e sociale di fronte al quale bisognerebbe unicamente inchinarsi. Scorsese lascia uno spiraglio aperto pure per noi ed è lì che lo struggimento del protagonista diventa collettivo. Un regalo fatto attraverso Netflix ma che non tutti avrebbero meritato.

16.Peterloo. Mike Leigh firma uno dei suoi film più belli e incompresi di sempre. La lezione pittorica di Turner è ancora nell’aria ed è evidente in quegli squarci di luce che accarezzano le composizioni umane e domestiche degli interni poveri e popolari. La lezione politica invece è affidata alle parole e ai discorsi, mai così fitti, impetuosi e appassionanti. Un’oratoria così ben gestita da farsi essa stessa protagonista attiva insieme agli attori (e in controtendenza rispetto al cinema di oggi che tende a imprimere movimento anche fine a se stesso). Il finale, con quella strage di piazza ripresa da un carrello circolare nella polvere, fa ancora male. Una lezione di storia che i libri non hanno mai raccontato.

17.Noi. Dopo “Scappa-Get out” un horror sociale ancora più grande di quello firmato nuovamente Jordan Peele. Dal tema razziale del nero -integrato, divorato e digerito dall’upper class bianca e benestante- a quello politico della controparte nera che vive nell’ombra, già espunta e vomitata dal sistema. Sopra un Luna-Park innocente, sotto camere di contenimento del rimosso. E’ solo l’America (U.S.) o siamo tutti Noi? Stratificazione tematica di fondo e sprazzi di ironia molto scary. Ma alla fine a restare impressi ci sono una grande Lupita Nyong’o e quella catena umana a mo’ di faglia color vermiglio che attraversa la coscienza del paese come una ferita non cicatrizzata.

18.La belle époque. Il cinema francese che si fa manuale vivente di sceneggiatura. Nicolas Bedos è quello di “Un amore sopra le righe” e si vede. Storie che si inseguono, che si determinano reciprocamente, sovrapponendosi con grazia e innamorandosi (fra loro) proprio come i personaggi che raccontano. Per sintetizzarlo qualcuno ha scritto un “Truman Show” al contrario. Sbagliando. La verità è che è impossibile definire (e raccontare) un’opera -che sconfina quasi nell’operetta- tanto radiosa e avvolgente come questa. C’è l’amore, lo sguardo malinconico verso il proprio catalogo di ricordi, il senso del cinema moderno e il gusto per una narrazione antica. Ci sono i disegni, gli storyboard e infine le sequenze. C’è l’epoca moderna e poi c’è, appunto, la belle époque (rigorosamente in minuscolo). Un gioiello raffinato e splendente.

19.Climax. Un altro intruso (è del 2018) uscito solo quest’anno ma che sarebbe impossibile non citare. “Questo è un film francese e ne è orgoglioso”. Basterebbe questa frase urlata a tutto schermo (tricolore) a rendere già il film inviso ai più (e infatti così è stato). Ma “Climax” è un’esperienza sensoriale presuntuosa e totale e come tale va preso. Perché a parte l’iniziale coreografia dell’incipit (splendida e godibile anche per chi detesta il film) il resto della narrazione è un racconto di pura dipendenza visivo-sonora che aggancia le sinapsi e ci annega nella sua sangria. C’è pure un diavolo che tira le fila e i dannati che si contorcono sotto di lui ma non è rilevante. Immerso in un rosso psicotico che non lascia scampo Climax è l’acme infilmabile dell’esperienza. Che Caspar Noè filma per noi.

20.Benvenuti a Marwen. Robert Zemeckis è forse uno degli autori americani più audaci degli ultimi trent’anni. Non solo perché si ostina a esplorare pioneristicamente l’effetto speciale (la cui esibizione nel cinema moderno si è fatta quasi pornografica), ma soprattutto perché continua a sperimentarne gli effetti (e le ricadute semantiche) all’interno di forme narrative classiche, dimostrando che dovrebbe essere il cinema a metabolizzarlo invece di esserne fagocitato. In più è coraggioso perché fa tutto questo rischiando mezzi e capitali (The Walk) e soprattutto il proprio nome. Benvenuti a Marwen è una follia, di quelle che fanno bene al cinema, agli occhi e all’anima. Ma è anche una seduta di psicanalisi dolorosa e di plastica che non ha paura di indossare i tacchi a spillo e di trovare nuova coerenza nell’happy end.
(Fine prima parte. Continua)

























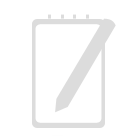

Commenti recenti